«Questo pomeriggio, in pianura, avvicinandomi a Denver, ho avuto la netta sensazione di… aver trovato finalmente il mio mondo. […] il sole avvampava tra le nubi temporalesche sopra una distesa di brune pianure dove si levava una sola fattoria… così che la fattoria, dal mio punto di vista, riceveva il rossore di Dio stesso»¹. Chissà se per Jack Kerouac, autore di questa frase, il «rossore di Dio» è quello che tinge di imbarazzo le guance o avvampa di furore il viso. O è solo il colore rassicurante di un tramonto intramontabile.
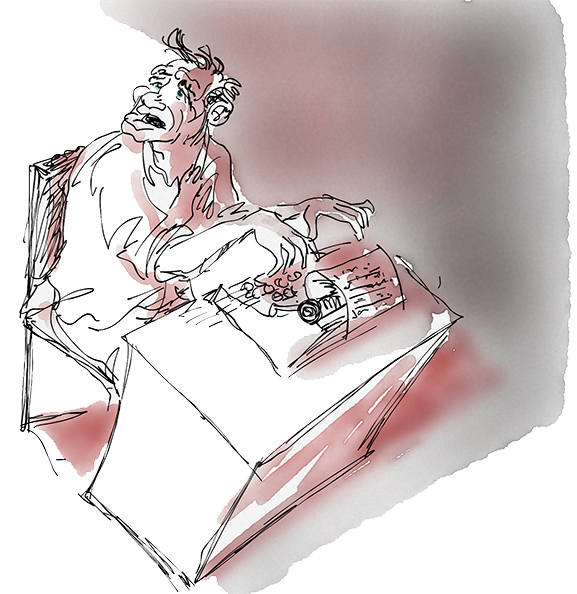
È il maggio del 1947 quando il futuro padre della beat generation scrive le righe sopra citate all’amico Hal Chase: il lungo viaggio di Kerouac alla ricerca del suo mondo, tradotto poi nel celeberrimo romanzo Sulla strada (On the road), in realtà, doveva ancora cominciare.
Avrebbe attraversato l’America, tra amori mercenari, topaie di periferia, benzedrina, marijuana e whiskey, lamenti di tromba nella notte e pianure infinite. E forse non approdò mai davvero alla quiete di una meta raggiunta. Continuò a contorcersi tra le ambizioni dello Spirito e il richiamo dello spirito. Ma questa distanza da una fede tiepida forse sarebbe piaciuta al cattolicissimo scrittore francese Leon Bloy, che più di tutto disprezzava l’ignavia, e più di tutte quella dei cristiani («Ogni cristiano senza eroismo è un porco»).
Il diario
di un credente
Nei diari pubblicati postumi, nel 2004 in USA e nel 2006 in Italia, riuniti nel volume Un mondo battuto dal vento, Jack Kerouac annota: «Fu da cattolico […] che un pomeriggio andai nella chiesa della mia infanzia (una delle tante), Santa Giovanna d’Arco a Lowell, in Massachusetts, e a un tratto, con le lacrime agli occhi, quando udii il sacro silenzio della chiesa (ero solo lì dentro, erano le cinque del pomeriggio; fuori i cani abbaiavano, i bambini strillavano, cadevano le foglie, le candele brillavano debolmente solo per me), ebbi la visione di che cosa avevo voluto dire veramente con la parola “Beat”, la visione che la parola Beat significava beato».
In una intervista rilasciata alla TV canadese francofona – dove appare ebbro, ciondolante e annoiato – racconta lo stesso episodio, scandendo bene la parola «beato» in italiano.
Il Beat, naturalmente, evocava anche i colpi di percussione della musica jazz, o le persone percosse dall’emarginazione e dalla povertà. Ma al fondo di questa ricerca sincopata e spesso dissoluta, apparentemente senza scopo e meta, Kerouac intravede in realtà un orizzonte.
Non tutto è morto
Nell’attacco di On the road si legge: «La prima volta che incontrai Dean fu poco tempo dopo che mia moglie e io ci separammo. Avevo appena superato una seria malattia della quale ora non mi prenderò la briga di parlare, sennonché ebbe a che fare con la triste e penosa rottura e con la sensazione da parte mia che tutto fosse morto».
Eppure, Kerouac non è un narratore disgustato dalla vita. Odia le elucubrazioni interiori (alienate?) alla James Joyce, senza la fatica di una forma narrativa. «Credo nella scrittura sana – confessa a se stesso – anziché nella brodaglia psicotica di Joyce. Joyce è un uomo che ha semplicemente smesso di comunicare con gli altri esseri umani. Lo faccio anch’io quando sono tormentato e ubriaco di stanchezza, perciò so che non è così onesto, anzi è addirittura crudele uscirsene con associazioni di idee senza l’autentico sforzo umano di trovare e dare ai propri discorsi un’intelligenza significativa. È un tipo di idiozia sdegnosa»
I suoi diari sono animati da un bruciante desiderio di conoscere, vedere, indagare la realtà, che, pur nelle sue dolorose contraddizioni, non è giudicata persecutoria o lontana.
«Scrivere – annota nel 1949 – non vuol dire prepararsi a litigare o a lottare con la realtà, tenendo il broncio con la sensazione di essere stati “esclusi” o qualcosa di simile. Partecipare ai fatti! È proprio come unirsi al resto dell’umanità». Non viaggia per fuggire, ma per incontrare.
Nel suo primo romanzo, La città e la metropoli (1950), racconta la diaspora di una famiglia americana. Il giornale inglese Sunday Mercury vi lesse la tesi che «il nucleo familiare è più forte dei mali della moderna civilizzazione». Non è un caso che, negli anni della stesura del libro, Kerouac annoti: «Se riuscirò mai a riconciliare l’autentico cristianesimo con lo stile di vita americano, lo farò ricordandomi di mio padre Leo, un uomo che li conosceva entrambi».
Il mio regno, non è
di questo mondo
Lo scrittore coltiva un desiderio febbrile di muoversi, di setacciare ogni palmo di terra americana, di percorrere tutte le rotte, di cercare la bellezza nella polvere dei sottoscala, ma intravede sempre una meta più lontana, un Altrove che riassumerà tutto e a tutto darà un senso.
Scrive nel 1947: «La terra sarà sempre la stessa, soltanto la città e la storia cambieranno e così faranno le nazioni, i governi e i politici si avvicenderanno, le cose create dagli uomini continueranno a cadere a pezzi: solo la terra rimarrà uguale a se stessa, ci saranno sempre uomini sul pianeta ogni mattino, resteranno le cose plasmate dalle mani di Dio e tutta questa storia fatta di città e congressi a un certo punto svanirà».
E ancora, in quello stesso anno: «“Il mio regno non è di questo mondo” Ascoltatelo solo un’altra volta, è il suono più squillante di tutti i tempi…».
A distanza di dieci anni, in un articolo del 1957, lo scrittore così descrive il fenomeno beat: «Una religiosità ancora più profonda, il desiderio di andarsene, fuori da questo mondo (che non è il nostro regno), in alto, in estasi, salvi, come se le visioni dei santi claustrali di Chartres e Clairvaux tornassero a spuntare come l’erba sui marciapiedi della Civiltà stanca e indolenzita dopo le sue ultime gesta».
Nel suo percorso incrocerà anche il Buddhismo, sebbene nel 1955 scriva, in una lettera indirizzata a John Clellon Holmes: «E ora Neal è veramente un santo – dice che Gesù è costantemente al suo fianco – Buddha è al mio – ma qui si tratta solo di personalità, nomi, metafore – tutte le cose sono forme diverse assunte dalla stessa santa essenza». Non è con questo epitaffio vagamente new-age ante litteram, tuttavia, che Kerouac si congederà dal mondo. Nove giorni prima di morire, in una intervista al reporter del St. Petersburg Times, Jack McClintock, il 12 ottobre 1969, dichiara: «Non sono un beatnik, sono un cattolico».
Non sono un beatnik
Non era certo la prima volta che Jean-Louis Lebris de Kerouac, successivamente noto come Jack per l’errore di un parroco, palesava la sua fede, rimasta tuttavia sconosciuta ai più per molti anni. In una conversazione con William F. Buckley Jr. (Visibile su YouTube) maltratta i bohémien e i comunisti, come Ferlinghetti, che sono «saliti sul carro” del movimento beat, trasformandolo in un inno alla ribellione, termine mai usato da Kerouac «in quanto cattolico» (“being catholic”). La sua vita e le sue opere ispireranno migliaia di giovani, in cerca di una vita “maledetta”, trasgressiva se non rivoluzionaria. Ma il loro modello non era particolarmente interessato alle rivolte di piazza, neppure durante la crisi del Vietnam, che nella stessa intervista definisce senza troppo rispetto «Un complotto del Nord e del Sud per avere delle Jeep».
Lo scrittore ebbe una vita sentimentale e sessuale disordinata. Come è giusto che sia, i diari restituiscono un’immagine contraddittoria e complessa. «Nella moralità – riflette dopo avere letto i saggi di Tolstoj – risiede una lugubre senilità che è priva di vita vera».
Kerouac è ambizioso, desidera scrivere un romanzo profetico come il Moby Dick di Melville o i Fratelli Karamazov di Dostoevskij. L’autore russo, in particolare, è più volte menzionato come punto di riferimento morale, oltre che artistico. «Ho concluso – scrive in una pagina di diario del ’47 – che quella di Dostoevskij è la più alta forma di saggezza al mondo, perché non è solo la sapienza di Cristo, ma di un Cristo Karamazov della lussuria e della gioia».
Nel lavoro, è molto più metodico e preciso di quanto si possa immaginare, e terribilmente fiero di esserlo. Annota con orgoglio il numero di parole che riesce a scrivere ogni giorno, come se rincorresse un record. Anche se si tratta di annotazioni personali, si ha spesso la sensazione che l’autore immaginasse già il giorno in cui un vasto pubblico le avrebbe lette e giudicate.
Kerouac vuole lasciare una traccia profonda in quella storia che pure riconosce destinata alla dissoluzione, e nei confronti della quale prende in prestito una definizione di James Joyce: «Un incubo dal quale non mi sono ancora svegliato». E, tra una continua ricerca di umiltà e di “obbedienza”, fra mille richieste di perdono per i suoi peccati, tra i miraggi del suo nome in mezzo ai grandi della letteratura, l’impronta è certamente rimasta.
Un museo per Jack
Oggi la pettinata città di Lowell, dove lo scrittore è cresciuto e ha studiato con i gesuiti, gli dedica un monumento nel parco che porta il suo nome, tra salici piangenti, edifici in mattoni rossi e aiuole vergini. Ogni anno decine di “pellegrini” cercano i primi passi della strada di Kerouac, e gli lasciano biglietti sulla tomba. Nel 2022, ce ne furono molti di più, per festeggiare i 100 anni dalla nascita di questo geniale narratore, che ispirò un’intera generazione e continua a ispirare uomini e donne, toccati dallo stile vibrante e sincero della sua scrittura e forse altrettanto tormentati dal vuoto esistenziale.
Presto potrebbe diventare realtà un museo dedicato al romanziere, nella chiesa di Giovanni Battista (Jean Baptiste church) di Lowell, dove nel 1969, in un gelido giorno d’ottobre, il mondo e i gli amici più intimi salutarono le spoglie mortali di Kerouac.
E chi potrà scandalizzarsi se un ubriacone selvatico, uno spavaldo cantore di prostitute messicane che ha negato il padre a una bambina sarà ricordato in un luogo sacro? Fu Gesù stesso a invitare nel suo regno un ladro, che moriva sulla croce accanto a lui.
Quella stessa crocifissione che appare in un dipinto firmato da Kerouac e Franco Angeli, e fa bella mostra di sé in un ampio soggiorno affacciato su piazza Navona a Roma, nella casa dell’attrice Armenia Balducci, già moglie di Gian Maria Volonté.

È lo scrittore, che ama disegnare e adorna con crocifissi molte pagine dei suoi diari, a suggerire un tema sacro ad Angeli, ateo figlio di atei a dispetto del nome. Perché Cristo è, stiamo alle parole di Kerouac, the only soul and the only answer. «Tutto ciò di cui scrivo è Gesù» dichiara durante un’intervista del 1968 con Ted Barrigan di The Paris Review e, successivamente, aggiunge che On the Road «era davvero una storia su due amici cattolici che vagavano per il paese alla ricerca di Dio». Parola di uno strano fedele.
